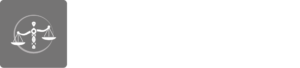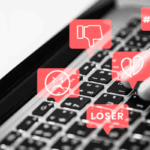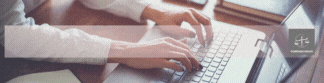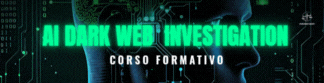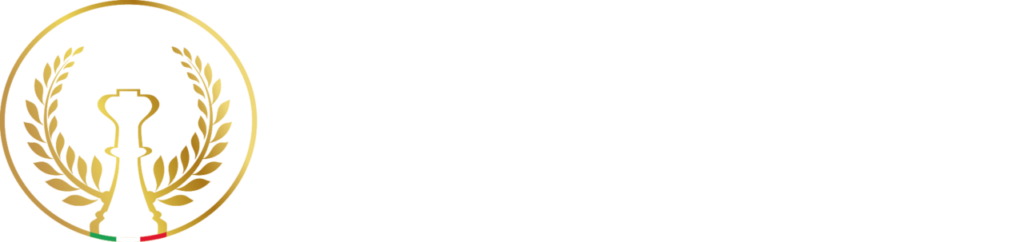In un’epoca in cui la sicurezza nazionale e la tutela dei diritti umani sono al centro del dibattito pubblico, il nuovo decreto sicurezza rivoluziona la disciplina della revoca della cittadinanza, ridefinendo i confini tra protezione collettiva e libertà individuali. La recente riforma, racchiusa nel Decreto Legge 48/2025, si distingue per un approccio innovativo: introduce sofisticate garanzie contro l’apolidia e rafforza i meccanismi di controllo, offrendo un modello dinamico e bilanciato in linea con le più avanzate esperienze europee. Attraverso un’analisi comparata, il lavoro svela come l’Italia si stia ponendo in prima linea nella ricerca di soluzioni giuridiche capaci di rispondere alle sfide globali senza sacrificare i valori costituzionali. Un laboratorio normativo che mette alla prova i concetti di cittadinanza, appartenenza e responsabilità, con uno sguardo attento alle prospettive di evoluzione futura e al ruolo cruciale della cooperazione internazionale.
L’approvazione del decreto legge 48/2025, convertito con modifiche nella legge 80/2025, segna una svolta significativa nella disciplina della revoca della cittadinanza italiana per reati di terrorismo ed eversione. L’articolo 9 di questo provvedimento interviene profondamente sull’art. 10-bis della legge 91/1992, introdotto dal controverso decreto sicurezza del 2018, apportando modifiche sostanziali che rispondono alle pressanti critiche dottrinali e alle problematiche di compatibilità con il diritto internazionale emerse negli anni precedenti.
Il quadro normativo preesistente al decreto sicurezza e le sue criticità
La disciplina della revoca della cittadinanza per reati di terrorismo, introdotta dall’art. 270-ter c.p. e dall’art. 270-quinquies.2 c.p., aveva suscitato fin dalla sua introduzione nel 2018 forti perplessità nella comunità giuridica. La norma originaria prevedeva la possibilità di revocare la cittadinanza italiana acquisita per matrimonio, naturalizzazione o ai sensi dell’art. 4, comma 2, della legge 91/1992, in caso di condanna definitiva per specifici reati legati al terrorismo e all’eversione dell’ordine costituzionale.
Le fattispecie interessate
Le fattispecie interessate dalla revoca comprendevano i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordinamento costituzionale per i quali la legge prevede la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a cinque anni o nel massimo a dieci anni; inoltre, la misura si applicava anche ai reati di ricostituzione di associazioni sovversive, partecipazione a banda armata, assistenza agli appartenenti ad associazioni sovversive e sottrazione di beni sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento del terrorismo.
La formulazione originaria presentava tuttavia una lacuna fondamentale: non prevedeva alcuna clausola di salvaguardia contro la creazione di situazioni di apolidia, configurando un potenziale contrasto con la Convenzione delle Nazioni Unite sulla riduzione dei casi di apolidia del 1961, ratificata dall’Italia con legge 162/2015. Questa omissione aveva sollevato immediate preoccupazioni circa la compatibilità della norma con gli obblighi internazionali assunti dal nostro Paese.
Le innovazioni del decreto legge 48/2025 cd. decreto sicurezza
L’art. 9 del decreto legge 48/2025 interviene con due modifiche sostanziali che trasformano radicalmente l’impianto della revoca della cittadinanza. La prima e più significativa innovazione riguarda l’introduzione di una clausola di salvaguardia contro l’apolidia. La nuova formulazione stabilisce espressamente che la revoca può essere disposta solo a condizione che il soggetto condannato “possieda” un’altra cittadinanza ovvero ne “possa acquisire” altra.
Questa modifica rappresenta un allineamento fondamentale con i principi del diritto internazionale e, in particolare, con l’art. 8, paragrafo 1, della Convenzione delle Nazioni Unite sulla riduzione dei casi di apolidia, che stabilisce il divieto per gli Stati contraenti di privare una persona della sua cittadinanza qualora tale privazione rendesse la persona apolide. La ratio della riforma, come esplicitato nella relazione illustrativa, è proprio quella di prevenire situazioni di apolidia che si verrebbero a creare laddove, in caso di revoca della cittadinanza italiana, l’interessato non possieda o non possa acquisire altra cittadinanza.
La seconda innovazione significativa riguarda l’estensione del termine per l’adozione del provvedimento di revoca, che passa da tre a dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna. Questa modifica risponde alle esigenze operative dell’amministrazione e tiene conto della complessità delle valutazioni necessarie per l’applicazione della misura, consentendo un più ampio margine temporale per le verifiche relative al possesso o alla possibilità di acquisizione di altra cittadinanza.
Il decreto sicurezza in materia di revoca della cittadinanza e la compatibilità con il diritto internazionale e europeo
L’introduzione della clausola anti-apolidia rappresenta un passo decisivo verso la piena compatibilità della normativa italiana con gli standard internazionali. L’art. 22 della Costituzione, che vieta di privare della cittadinanza per motivi politici, trova ora un bilanciamento più equilibrato con le esigenze di sicurezza nazionale, attraverso una disciplina che esclude la possibilità di creare situazioni di apolidia.
La riforma si allinea inoltre con l’approccio adottato da altri ordinamenti europei, come quello francese, che da tempo subordinano la revoca della cittadinanza al possesso di una doppia nazionalità. Questo orientamento riflette una concezione moderna del diritto alla cittadinanza che, pur riconoscendo la legittimità di misure sanzionatorie per gravi reati contro la sicurezza dello Stato, non può spingersi fino a privare completamente una persona di ogni legame giuridico con una comunità statale.
La revoca della cittadinanza prevista dal decreto sicurezza: bilanciamento tra sicurezza e diritti fondamentali
La riforma del 2025 rappresenta un tentativo di trovare un equilibrio più sostenibile tra le esigenze di sicurezza nazionale e la tutela dei diritti fondamentali. L’estensione del termine da tre a dieci anni per l’adozione del provvedimento di revoca consente all’amministrazione di effettuare valutazioni più approfondite e ponderate, tenendo conto non solo della gravità del reato commesso ma anche dell’evoluzione della situazione personale del soggetto e delle possibilità concrete di acquisizione di altra cittadinanza.
Questo approccio riflette una concezione più matura della lotta al terrorismo, che non sacrifica i principi fondamentali dell’ordinamento sull’altare dell’efficacia repressiva. Come evidenziato dall’art. 3 della Costituzione, che sancisce il principio di uguaglianza, la disciplina della cittadinanza deve evitare discriminazioni irragionevoli tra cittadini per nascita e cittadini naturalizzati, pur riconoscendo la legittimità di differenziazioni fondate su ragioni oggettive e proporzionate.
Il decreto sicurezza in materia di revoca della cittadinanza: implicazioni procedurali e processuali
L’estensione del termine a dieci anni comporta la necessità di un monitoraggio più prolungato delle situazioni soggettive e richiede all’amministrazione di sviluppare procedure più sofisticate per la verifica del possesso o della possibilità di acquisizione di altra cittadinanza.
La natura discrezionale del provvedimento di revoca, già riconosciuta dalla giurisprudenza amministrativa, trova ora un ulteriore elemento di complessità nella valutazione delle condizioni anti-apolidia. Come chiarito dalla giurisprudenza, il conferimento della cittadinanza italiana per naturalizzazione costituisce atto di alta amministrazione caratterizzato da ampia discrezionalità, e tale discrezionalità si estende necessariamente anche alle valutazioni relative alla revoca.
La revoca della cittadinanza e le prospettive future
L’allineamento della disciplina italiana agli standard internazionali rappresenta un importante passo verso l’armonizzazione delle normative europee in materia di revoca della cittadinanza. L’esperienza di altri ordinamenti, come quello francese con la déchéance de nationalité, dimostra che è possibile conciliare le esigenze di sicurezza con il rispetto dei diritti fondamentali attraverso un sistema di garanzie procedurali e sostanziali.
La riforma italiana si inserisce in un più ampio movimento di revisione delle politiche di cittadinanza a livello europeo, caratterizzato da una maggiore attenzione ai profili di tutela dei diritti umani e di compatibilità con il diritto dell’Unione europea.